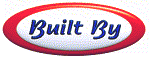COMUNE DI RE
Piazza Santuario, 3 - 28856 RE (Verbania)
Municipio:  ++39.0324.97012
- fax ++39.0324.97012
++39.0324.97012
- fax ++39.0324.97012
Altitudine mt. 710 slm. - abitanti: n. 933 - frazioni: Folsogno,
Meis, Dissimo, Olgia.
Feste patronali: S. Maurizio (15 Gennaio) - Ricorrenza del Miracolo
con fiera (29/30 Aprile e 1° Maggio).
|
1 - RE E LA VALLE
VIGEZZO
|
|
Re deve la sua importanza alla
prodigiosa effusione di sangue avvenuta nel 1494 sopra un
affresco raffigurante una Madonna del latte. Geograficamente
è situato nella Valle Vigezzo orientale in provincia
di Verbania a 7 chilometri dal confine con la Svizzera
(Canton Ticino) a 710 mt. di altitudine. Collocato sulla
sponda sinistra del Melezzo orientale , deriva il suo nome
dal dialetto "Ri" (torrente), mentre l'agglomerato
più popoloso del paese è situato più in
alto sul dorso della montagna con il nome Folsogno. La Valle
Vigezzo appartiene alle Alpi Lepontine ed è
costituita da un ampio altopiano, disposto in senso
longitudinale da est ad ovest, aperta, a differenza della
maggior parte delle valli, sui due versanti. Ad ovest si
affaccia alla visione
|
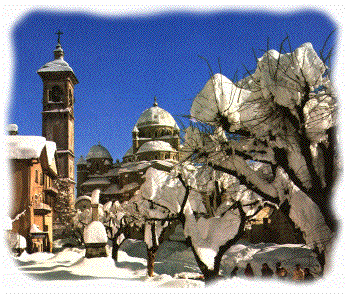
|
|
maestosa dei ghiacciai del Monte
Rosa e delle Alpi Pennine. Da questo può derivare il
suo nome (video glacies) o più probabilmente dalla
sua origine geologica che, nel periodo quaternario, la vede
trasformarsi in palude ("uezza"). In seguito l'erosione
delle sponde sui due versanti, si sono formati i due corsi
d'acqua denominati "Melezzo Orientale" e "Melezzo
Occidentale" che percorrono la Valle, il primo verso la
Svizzera (Centovalli) e il secondo verso l'Italia
(Domodossola). Nel tratto di fiume di fronte a Re affiorano
sedimenti di argilla ricchi di fossili (filliti
quaternarie). La Valle Vigezzo, per la condizioni favorevoli
del suo clima, fresco d'estate e secco d'inverno, è
molto frequentata da villeggianti e da turisti. E' ricca di
vegetazione e rinomata come la "Valle dei pittori" grazie
alla luminosità del suo cielo e alla varietà
dei colori autunnali che hanno ispirato i pennelli di
celebri artisti quali il Borgnis, il Peretti, il Cavalli, il
Lupetti, il Rossetti Valentini, il Fornara. Alcuni dei loro
affreschi figurano nelle belle chiese della valle. In alta
quota le numerose cime, che superano quasi tutte i duemila
metri, offrono agli appassionati di alpinismo itinerari
suggestivi. Si raggiunge la valle da Domodossola con la
Strada Statale n. 337 molto scorrevole e transitabile anche
da grossi torpedoni; e da Locarno attraverso la strada delle
Centovalli. I due capoluoghi sono collegati anche dal
trenino della Ferrovia Vigezzina con un percorso
spettacolare in mezzo ai boschi e sospeso in molti tratti su
arditi ponti aerei. La Valle Vigezzo è pure collegata
al Lago Maggiore attraverso la tortuosa strada della Valle
Cannobina.
|
|
2 - IL MIRACOLO DEL
SANGUE
|
|
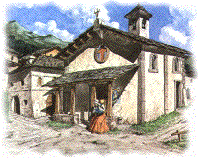
|
Erano le ore 23 del 29 aprile del
1494. In quel tempo la giornata era divisa in 24 ore, dal
tramonto al tramonto, finiva ed iniziava l'imbrunire. Era un
martedì. Ciò che accadde non può
ritenersi una leggenda, poiché e ben documentato in
due pergamene autentiche di quell'epoca, firmate dai
podestà della Valle, Daniele Crespi e Angelo Romano,
e controfirmata, la prima, da quattro notai, i cui nomi
figurano negli archivi comunali di alcuni paesi vigezzini.
Un'ora prima del tramonto un certo Giovanni Zucono
(soprannominato poi "Zuccone") assieme con l'amico Comolo
giocava alla "piodella" sulla piazzetta antistante la chiesa
del paese, dedicata a S. Maurizio.
|
|
Il gioco consisteva nel porre sopra
un bussolotto di legno o di sasso (il "mago") una moneta per
ciascun giocatore. Viceversa chi colpendo il "mago" con la
piodella (una scheggia di sasso rotondeggiante) "riusciva a
spargere le monete intorno facendo sue quelle più
vicine alla "piodella". Lo Zuccone, già noto per il
suo carattere furioso, quella sera era perdente, "non
sappiamo quanto denaro, ma a sufficienza per scatenare in
lui la collera e l'irrazionalità che si nasconde in
ognuno di noi quando ci sentiamo perseguitati dalla
sfortuna". E lo Zuccone se la prende con la tranquilla
immagine della Madonna che è li a pochi passi sotto
il porticato della chiesa, dipinta sulla
facciata,
|
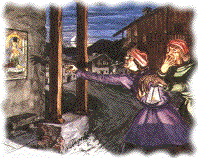
|
|

|
a destra della porta di entrata e
che sembra non occuparsi delle disavventure dello Zuccone.
Accecato dall'ira scaglia la "piodella" contro l'immagine e
la colpisce in fronte. "Poltron, lo rimprovera il compagno
Comolo, hai tratto alla Vergine Maria!". Lo Zuccone rientra
in se stesso e preso da rimorso, si inginocchia davanti alla
Madonna e chiede perdono.
|
|
Lo Zuccone rientra in se stesso e
preso da rimorso, si inginocchia davanti alla Madonna e
chiede perdono.
|

|
|

|
Poi, colti tutti due da una
sensazione di paura; fuggono, Prima ancora dei segni
prodigiosi che stanno per manifestarsi sulla sua immagine
colpita in modo sacrilego, la Madonna ha già compiuto
il primo miracolo nel cuore del suo aggressore. Nella notte,
verso le 11, prima Giovanni di Minola di Re e poi Antonio
Ardicio di Craveggia, passando davanti alla chiesa, notano
un chiarore insolito sotto il porticato come se vi fosse una
candela accesa. Anch'essi, presi da paura, si allontanano in
fretta.
|
|
Prima dell'alba il sagrestano
Stefano di Gisla, mentre si accinge ad aprire la chiesa per
il suono dell'Ave Maria, trova inginocchiata davanti
all'immagine una donna vestita di bianco; crede di
riconoscere una sua vicina di casa e la saluta senza
ricevere risposta; ma non si accorge di cosa stà
avvenendo sull'affresco.
|

|
|

|
Esce quasi subito dalla chiesa e non
trova più la donna. Sarà un vecchietto di nome
Bartolomeo a scoprire per primo l'avvenimento
prodigioso.
|
|
Nel gesto devoto di toccare
l'immagine della Madonna e di baciarsi la mano, s'accorge
con stupore che è bagnata di sangue. Guarda la
Madonna e vede che dalla ferita della testa esce un
rigagnolo di sangue. Corre a chiamare il rettore della
chiesa don Giacomo. Suonano le campane a distesa e la
notizia si propaga di casa in casa, di paese in
paese.
|
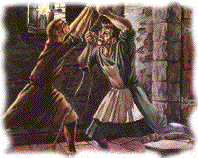
|
|
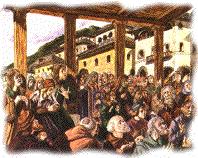
|
La gente accorre e si accalca sotto
il portico della chiesa con gli occhi fissi sull'immagine
insanguinata implorando ad alta voce: "Misericordia,
misericordia". "Pareva che la terra
tremasse".
|
|
Per tutto il giorno e la notte
successiva molte persone rimangono sul luogo del miracolo a
pregare con ceri accesi in mano. Dopo la mezzanotte il
fiotto di sangue cresce e gocciola fino a terra emanando un
profumo soave "impossibile a descriversi". Sul pavimento si
tampona il sangue con "pannolini bianchi" che poi il parroco
raccoglie in una tovaglia e ripone in un calice. L'effusione
di sangue dura una ventina di giorni fino al 18 maggio in
modo intermittente e sempre meno abbondante come da una
ferita che a poco a poco si rimargina. Ad ogni emissione di
sangue, si annuncia l'evento con il suono delle campane; al
richiamo, il popolo accorre "di giorno e di
notte".
|
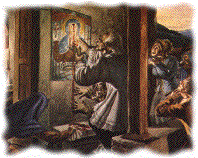
|
|
3 - LA PERGAMENA DEL
PODESTA’ DANIELE CRESPI
|
|
Il primo documento che comprova
l'autenticità del miracolo di Re è la
pergamena del Podestà della Valle Vigezzo Daniele
Crespi di Busto Arsizio, un atto pubblico firmato da lui
stesso e controfirmato da quattro notai: Pierino balconi (lo
stesore della pergamena), Giovannino Rossi, Pietro Rossi e
Pietro Balconi. Quest'ultimo, cancelliere del
Podestà, chiude la pergamena di suo pugno con la
clausola di conferma. La pergamena, conservata nell'archivio
parrocchiale in discrete condizioni (manca del sigillo di
ceralacca), è scritta in latino con frequenti
abbreviazioni e contiene la dichiarazione del podestà
che attesta di essersi recato alla chiesa di Re con molti
"chierici e nobili uomini" della valle e di aver esaminato i
muri della chiesa "per vedere se il fatto fosse stato
provocato artificialmente"; convintosi che il "sangue era
sceso e scendeva miracolosamente... dalla fronte
dell'immagine", "sentito che un tal Giovanni Zuccone,
proprio in quello stesso martedì aveva scagliato un
sasso contro l'immagine", raccolte le testimonianze di
alcuni testimoni, invita i quattro notai a confermare la
solenne dichiarazione con il loro segno di tabellinonato
("una sorta di timbro personale e ufficiale fatto con un
ghirigorio a penna"). Fa anche un accenno generico "ai segni
prodigiosi" che seguiranno alla effusione miracolosa di
sangue e alla costruzione di un "nuovo tempio, maestoso" che
gli abitanti di Re non possono "portare a termine per
la
|
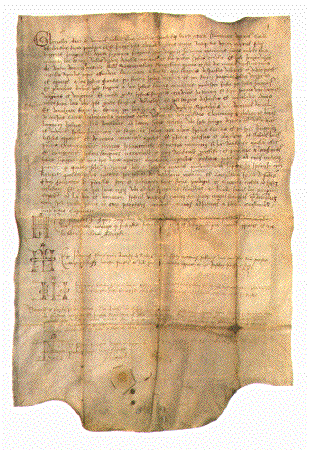
|
|
loro povertà" e quindi "si sentono
costretti ad implorare aiuti dai fedeli seguaci di Cristo".
L'edizione critica del documento fa osservare che i notai,
appartenenti a due famiglie divise tra loro da accanite
fazioni politiche, i Balconi e i Rossi, ora uniti in un
documento pubblico, così insolito nella loro
attività professionale, colgono nel sangue della
Madonna la grazia della riconciliazione.
|
|
4 - LA PERGAMENA DEL
PODESTA’ ANGELO ROMANO
|
|
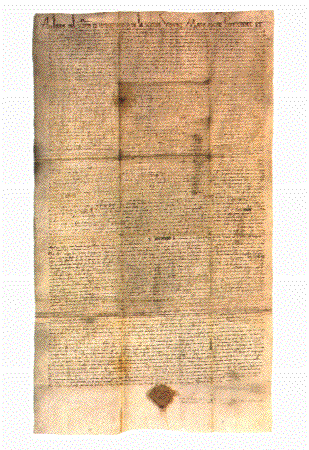
|
Il secondo documento comprovante la
verità storica del miracolo del sangue è
un'altra pergamena molto più estesa che sviluppa il
contenuto della precedente con i particolari
dell'avvenimento prodigioso e con l'elenco delle grazie.
Più della prima è pervasa dalla commozione e
dal sentimento religioso di devozione verso la Vergine.
Termina con un'esortazione simile ai sermoni dell'epoca con
qualche accenno apocalittico che rivela le paure per lo
svolgersi minaccioso degli avvenimenti politici e militari
di quel tempo e per le prime avvisaglie di altre fratture
nell'unità della Chiesa. "Questa è la donna
che mai alcun seme di qualità umana
contaminò... Farai bene, tu, se dentro di te
conserverai integri l'amore e la carità di questa
donna. Se il vizio ti acceca, i suoi begli occhi cercando,
Ella nell'intimo ti sanerà... Non si può sudar
sangue senza un grave dolore; Ella sparge il suo per salvare
il nostro... Corriamo a vedere il suo sangue... non
tardiamo, non tardiamo perché l'anno della vendetta
dei nostri peccati stà per avvicinarsi... La
pregheremo che il breve volger di tempo muti il parer del
Figlio. Altrimenti accadrà ciò che è
stato divisato: povertà, fame, pioverà sangue
sui campi e sui prati... verrà un tempo crudele
assai, nel quale anime perverse con le loro crudeltà
devasteranno la Chiesa. Il gran punire purificherà il
gran peccare... Alza la mente verso il primo amore! Da Lei
nasce ogni bene e perfezione...". Questa seconda pergamena,
scritta in italiano non puro nell'anno 1500, è stata
dettata dal podestà della Valle Angelo Romano, di
origine veneta, successore del Crespi.
|
|
Prima incredulo circa i fatti di Re,
non potendo resistere ad un richiamo interiore ("dentro di
me ero continuamente punzecchiato") si sente costretto a
recarsi a Re.
|
|
5 - IL
SANTUARIO
|
|
Nei cento anni successivi al
miracolo non fu possibile costruire quel" maestoso tempio" ,
cui si fa cenno nella pergamena del Crespi, a causa delle
tristissime vicende politiche ed altre calamità,
previste nella pergamena del Romano. Già sette anni
prima del miracolo la Valle che apparteneva al Ducato degli
Sforza dato in feudo ai Borromei, era stata saccheggiata e
depredata dai Vallesani e per tutto il secolo XVI
risentirà del passaggio nell'Ossola degli eserciti
francesi e spagnoli e dei tentativi insurrezionali di
scacciare lo straniero; e subirà, oltre le vessazioni
militari, anche quelle fiscali imposte dai padroni di turno,
in particolare dagli spagnoli. Inoltre dal 1513 al 1530 per
ben cinque volte il flagello della peste decimò
le
|
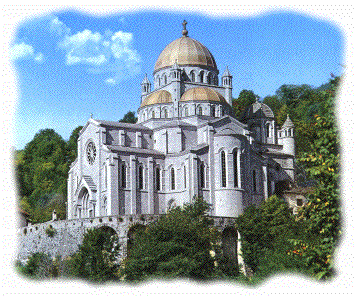
|
|
popolazioni. Alla fine del XVI
secolo si aggiunse la piaga del brigantaggio. Solo nel 1596
il venerabile Bescapè, vescovo di Novara, nella sua
prima visita pastorale, dà un impulso decisivo al
culto della Madonna del Sangue. Decreta delle disposizioni
severe relative alla custodia dell'immagine e delle reliquie
del sangue; con una lettera invita i Vicari foranei della
diocesi a far conoscere e venerare la Madonna di Re; e
sollecita la costruzione di un tempio degno del
miracolo.
|
|
Nel '700 viene costruito attorno
all'affresco del miracolo il pregevole altare di marmo
intarsiato con balaustra semicircolare, proveniente dalla
scuola lombarda. L'altare è stato concepito come
nicchia per incorniciare l'affresco e come trono della
Madonna per tributarle quel debito di onore e di amore quale
Madre di Dio e Madre della divina Grazia. Due angeli di
marmo bianco stanno in adorazione ai fianchi dell'affresco,
mentre sulla cuspide dell'altare sei angioletti in
composizione ovale sorreggono alla sommità una corona
per la regina del cielo e della terra.
|
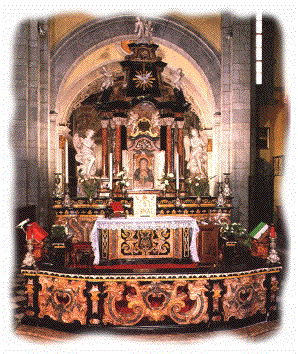
|
|
|

|
Vi ritorna nel 1603 ma trova le cose
come le aveva lasciate e richiede che si faccia almeno un
"vestibolo" attorno all'immagine del miracolo. Nella terza
visita del 1609 in una breve relazione manifesta la sua
"consolazione" nel vedere che "la fabbrica di questa chiesa
della Vergine faccia progressi grandi". Nel 1627 in Vescovo
Volpi può consacrare e inaugurare il Santuario di
stile corinzio ad una sola navata. Nel 1627 in Vescovo Volpi
può consacrare e inaugurare il Santuario di stile
corinzio ad una sola navata.
|
|
|
|
La parte più ardita del
tempio è sicuramente la cupola; si presenta maestosa,
sormontata da quattro vigili torri, agli occhi stupiti dei
turisti che si affacciano, d'improvviso, al grandioso
spettacolo, provenienti delle Centovalli Svizzere e dal
versante italiano. Si eleva nel cielo con spettacolare
maestoso ardimento fino all'altezza di 51 metri. E’
indubbiamente un pregevole lavoro di architettura che crea
una nota di particolare eleganza nel complesso armonioso
della costruzione.
|

|
|
|
Interno della Basilica della Madonna del
Sangue - La cupola centrale
|
|

|
L'immagine della Madonna di Re raffigura
con uno stile romanico bizantineggiante una delle Madonne
del latte, assai diffuse nel periodo tra il XIII e il XIV
secolo. Seduta in trono con Gesù Bambino benedicente
sulle ginocchia, la Madonna è rappresentata nella sua
funzione di madre-nutrice del Figlio di Dio, nella mano
destra ostenta tre rose, il "fiore delle vergini" e il
simbolo del Rosario. Ai piedi dell'immagine un cartiglio
annunzia il significato teologico della missione di Maria:
"In gremio Matris sedet sapientia Patris" ("In grembo alla
Madre stà la sapienza del Padre"), espressione tipica
dei Padri della Chiesa, non estranea alla cultura classica
pagana. La devozione popolare vedeva anche nel seno della
Vergine un segno di protezione e di buon auspicio rivolto
alle puerpere in tempi in cui non si trovavano "succedanei
al latte materno". Il pittore della Madonna di Re è
anonimo non avendo lasciato la firma né su questo
affresco né su altre opere da lui dipinte con uguali
caratteristiche sia in Ossola che fuori. A preferenza di
pittori celebri, è stato scelto dalla Provvidenza a
"creare" un'immagine che sarà strumento di grazia e
avrà larga diffusione in Italia e all'estero.
Soprattutto nelle case della Valle Vigezzo, della Valle
Cannobina, del Lago Maggiore e del Canton Ticino l'Immagine
della Madonna del Sangue ha un posto di onore; inoltre la
sua figura con la stimmate inconfondibile del sangue appare
dipinta dovunque sui muri esterni delle abitazioni e sulle
umili casere degli alpeggi. Grazie all'emigrazione vigezzina
prevalentemente
|
|
di spazzacamini, peltrai, rivenditori
ambulanti, pittori e gioiellieri, l'immagine della Madonna
del Sangue è giunta nei vari cantini svizzeri, nel
Tirolo, in Ungheria, in Austria, in Cecoslovacchia e fino
alle Americhe. A S. Paolo di Appiano (Tirolo) nel 1875
è stato eretto un Santuario dedicato alla Madonna di
Re; presso Ginevra in una cappella a Perlj la Madonna del
Sangue è stata riprodotta in una grande vetrata di
Alexandre Cingria; così pure sulla porta di legno del
tabernacolo della chiesa di Semsales in una scultura
policroma, opera di Marcel Feuillat. In Ungheria esistono
due santuari dedicati alla Madonna del Sangue: uno a
Budapest e l'altro a Gorcsonj
|


questo sito web è stato realizzato da Ermanno Cappini
architetto con:
Project WebMaster by  ,
Copyright © 1997-2000, All rights reserved Ermanno Cappini
architect
,
Copyright © 1997-2000, All rights reserved Ermanno Cappini
architect

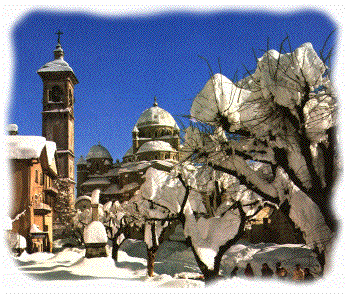
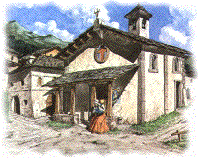
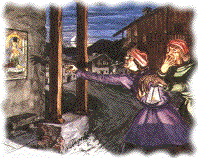





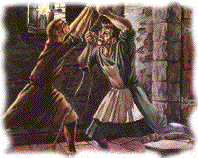
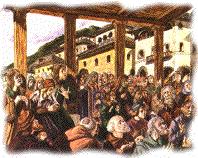
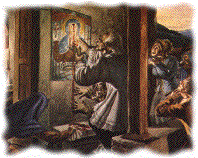
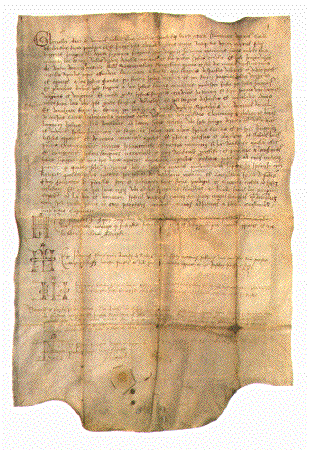
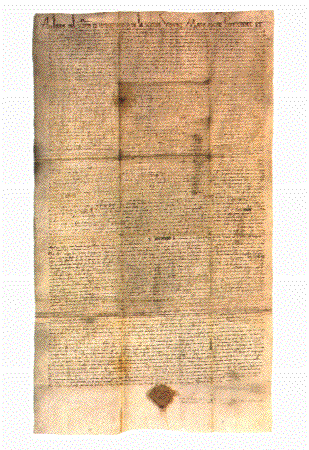
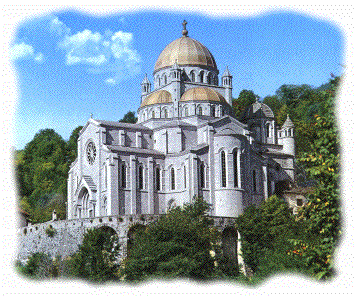
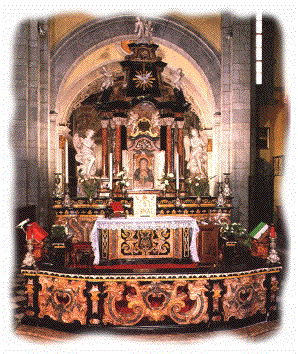




![]() ,
Copyright © 1997-2000, All rights reserved Ermanno Cappini
architect
,
Copyright © 1997-2000, All rights reserved Ermanno Cappini
architect